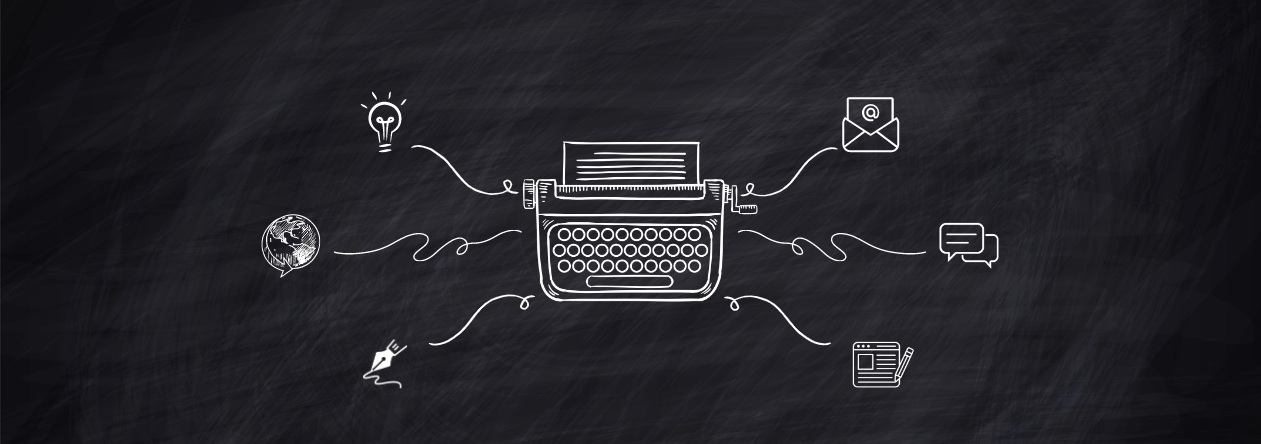Pisa, 15 febbraio 1564. Non sono la data e il luogo di un giorno o posto qualsiasi, ma quelli corrispondenti alla nascita di Galileo Galilei. Con lui scienza e astronomia hanno cambiato volto: Galilei, infatti, ha attuato una vera e propria rivoluzione scientifica.
Tra le tante innovazioni, una importantissima è quella del cannocchiale. È il 1609 quando Galilei, studiando lo strumento olandese, elabora un nuovo schema ottico, basato sulla combinazione di lenti concave e convesse. Ciò che oggi è conosciuto come “cannocchiale galileiano”, infatti, è il perfezionamento di quello olandese, anche se molti pensano che sia stato lo stesso scienziato toscano ad inventarlo. Questa convinzione, probabilmente, è dovuta al fatto che Galilei è stato il primo a puntare il cannocchiale verso il cielo, non usandolo più per gli scopi originari, ovvero civili e militari.

Attribuzione: Justus Sustermans, Public domain, Wikimedia Commons
Occorre sottolineare che questo ha rappresentato un grande passo: nessuno all’epoca avrebbe avuto il coraggio di andare contro il principio di autorità, l’“ipse dixit”, dal momento che i dotti erano coloro che studiavano ciò che era stato affermato in passato e lo prendevano come vero, senza dimostrarlo. Galilei, però, ha avuto il coraggio di unire il sapere teorico a quello pratico, e questo gli ha consentito di fare notevoli scoperte, come quella relativa ai satelliti di Giove. Al tempo, però, nessuno voleva credergli: chi lo accusava di essersi inventato tutto, chi non voleva nemmeno guardare il cielo attraverso il cannocchiale. La concezione della scienza era quella che rispecchiava le teorie aristoteliche: la Terra era al centro dell’universo, il quale era diviso in due zone, quella perfetta, dove si trovavano le stelle fisse, e quella imperfetta, dove erano situati aria, acqua, terra e fuoco. Nessuno, infatti, poteva opporsi a tutto ciò e chi, invece, sosteneva il contrario veniva considerato eretico. La pena, in questo caso, era molto pesante: o si abiurava, spesso per paura, oppure si veniva condannati a morte, come è successo a Giordano Bruno. La scienza, quindi, era molto limitata e si poteva indagare soltanto entro certi ambiti.
Oggi qual è la situazione della ricerca scientifica nel nostro Paese? Secondo dati recenti, gli investimenti per la ricerca in Italia sono inferiori a quelli di altri stati europei come Francia e Germania. Questo rappresenta spesso un problema, infatti chi non possiede fondi a sufficienza non può intraprendere un percorso di ricerca perché non può procurarsi gli strumenti adeguati, mentre chi è finanziato per un determinato campo di ricerca può approfondire ed indagare senza limitazioni. Quanto agli ambiti della ricerca scientifica, a livello europeo l’Italia è ben posizionata nell’area della ricerca medica e nelle Scienze Sociali, ma non in altri ambiti come le Scienze ambientali.
In conclusione, se all’epoca di Galilei gli scienziati erano limitati dal potere esercitato dalla Chiesa e da vecchie concezioni filosofiche, ora, invece, possono essere ostacolati dal denaro, o meglio dalla sua mancanza.
Alessia Barbieri