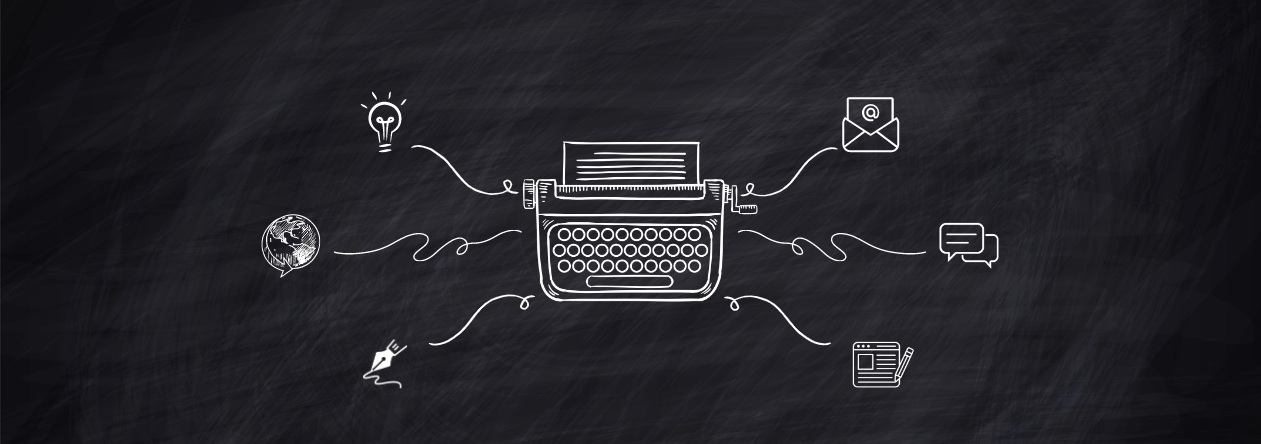In una società moderna che getta le basi della sua evoluzione sul consumismo sfrenato e sull’incessante insoddisfazione per ciò che si possiede, è inevitabile che anche il mondo relazionale-affettivo ne risenta in modo molto pesante, assumendo logiche di marketing tipiche dell’economia.
Con l’avvento del consumismo, il mondo si è trasformato in un grande mercato all’interno del quale ognuno percepisce la costante urgenza e responsabilità di comprare e finisce per non sentirsi mai soddisfatto di ciò che ha, tanto sono veloci i tempi di scelta imposti dalla società stessa. L’uomo ritorna quindi ad essere un bambino, nervoso quando non riesce a soddisfare i propri desideri, intollerante alla frustrazione e incapace di gestire l’attesa. Questa libertà di acquistare, consumare e buttare via, illude l’uomo di poter dominare il tempo dissolvendo il futuro nel presente, ma al contrario lo rende apatico e sofferente, producendo in lui un profondo stato di inadeguatezza, legato alla costante paura di non “restare al passo” con la realtà in cambiamento. È proprio quando l’uomo si sente inferiore, che la necessità continua di consumo si trasforma nel mezzo più semplice per scappare da sé e placare l’ansia di non essere abbastanza.
Il fenomeno “usa e getta” è diventato così presente nella quotidianità di ognuno di noi che ha preso forma anche all’interno delle relazioni. In questa nuova logica di materializzazione dell’amore, l’altro perde il suo valore umano e diventa un oggetto che si sceglie “a tavolino”, si usa e, alla prima difficoltà, invece di aggiustare ciò che non funziona, si getta via sostituendolo con qualcos’altro.
Questo amore “moderno”, evidentemente fragile, razionale, breve e superficiale, corrisponde per l’appunto all’amore liquido di cui parla Bauman. Questo legame è paragonato ad una zattera di carta assorbente per enfatizzarne la precarietà: come un naufrago non navigherebbe mai su una zattera in tali condizioni, così l’uomo non porrebbe mai fiducia in legami instabili. La relazione diventa quindi un semplice mezzo utilitaristico per sentirsi meno soli di fronte ad un mondo che ci rende insicuri, ma nella realtà l’uomo mantiene un principio di individualismo sfrenato che gli permette di liberarsi facilmente dell’altro nel caso in cui si notasse un difetto in lui.
Il problema sociale dell’instabilità relazionale deriva da un intero contesto culturale sempre meno capace di garantire stabilità alla società stessa. Di conseguenza, l’uomo si sente fragile ed incapace di costruire una relazione matura e profonda, per paura di soffrire e perché è convinto di non essere adatto a mantenere una relazione soddisfacente. Se pur presenta il desiderio di incontrare l’altro, non è in grado di avvicinarsi davvero per il costante timore di non essere soddisfatto abbastanza o di rimanere “impigliato” nella relazione.
Il distacco emotivo che si genera nelle relazioni, inoltre, impedisce ad ambedue le parti di provare empatia: infatti, in una cultura consumistica di soluzioni rapide, prodotti pronti per l’uso e soddisfazione immediata, non ci sono né tempo né energie necessarie per perdonare, scendere a compromessi o ricercare il modo di risolvere i problemi. La via più semplice è e sempre rimarrà quella della fuga, che allo stesso tempo non permetterà mai alla relazione di misurarsi con le difficoltà e di rafforzarsi.
A partire da noi giovani, tutti dovremo impegnarci nel riconoscere il valore umano dell’altro, che non è un “oggetto” di cui si può usufruire per colmare il proprio senso di vuoto, ma è un componente attivo nella relazione, che ci può aiutare a crescere e migliorare, attraverso il confronto.
Chiara Pira