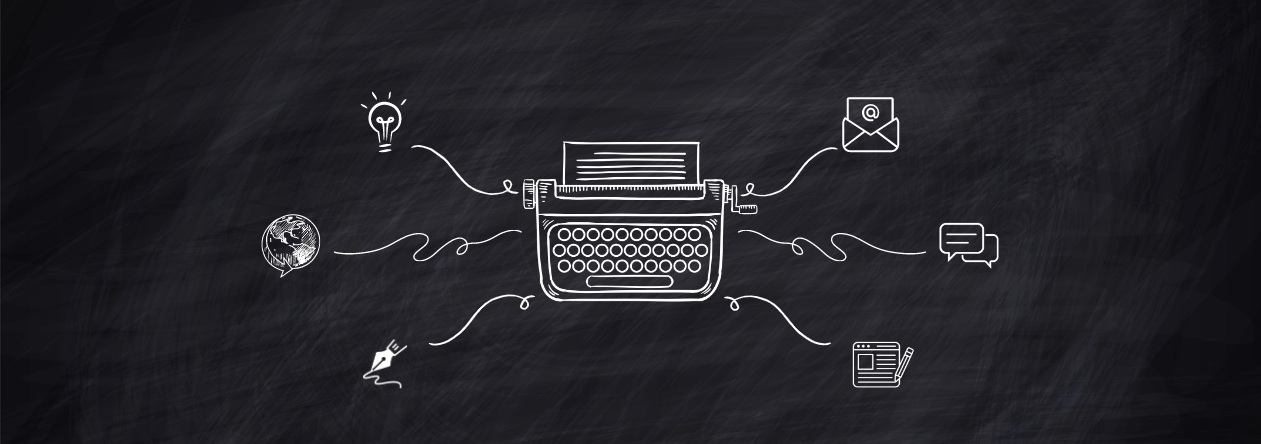Negli ultimi anni le nuove scoperte tecnologiche in ambito digitale e le nuove metodologie didattiche hanno contribuito a rendere più facile l’insegnamento e l’apprendimento. Ma allora come mai molti ragazzi sono ancora neet, cioè non studiano e non cercano lavoro?
Guardiamo, per farci un’idea, i risultati del 58° rapporto CENSIS su questo argomento, usciti nel 2024.
La produzione manifatturiera è calata del 1,2% dal 2019 al 2023 e del 3,4% fino ad Agosto del 2024; in cambio il turismo ha raggiunto nel 2023 i 447 milioni, con un incremento del 26,7% dal 2013. Inoltre continua ad esserci un grande divario economico fra nord e sud, per giunta in uno scenario che evidenzia un grande fabbisogno di personale qualificato, soprattutto cuochi, elettricisti, idraulici, artigiani e operai specializzati nei vari settori. C’è da considerare che nel 2024 il numero di occupati è salito a 23,8 milioni, ma l’Italia rimane l’ultimo paese rispetto all’Europa con il tasso di occupazione molto più basso della media, anche se si registra solo il 15,4% dei giovani neet, (- 28,3% rispetto al 2023). Si può anche aggiungere che il sistema educativo evidenzia carenze nei risultati, con il 43,5% degli studenti che non raggiunge i livelli minimi di apprendimento in italiano e il 47,5% in matematica.
Quanto e come incide la scuola nella fotografia dei giovani di oggi? Da sempre la scuola, in quanto istituzione educativa, ricopre un ruolo decisivo nella formazione e nella crescita di una persona, in particolare nella sua fase evolutiva. Tuttavia proprio in questi ultimi anni sembra che abbia perso la sua incisività nell’essere efficace.
Il problema, per me, risiede soprattutto nella metodologia utilizzata: le scuole non forniscono spesso ai discenti una didattica attiva. La maggior parte degli insegnamenti, infatti, avviene attraverso la spiegazione di contenuti che non arriva alla totalità della classe, poiché oggi i ragazzi vivono una vita molto frenetica, bersagliata da input provenienti da settori diversi, che cambiano velocemente e questo non favorisce tempi di riflessione e di concentrazione. C’è da aggiungere che una persona può, inoltre, preferire adottare uno stile “x”, (attivo/riflessivo, sensoriale/intuitivo, verbale /visivo, intuitivo/deduttivo e sequenziale/globale), piuttosto che quello dettato dall’insegnante. Perciò sarebbe meglio diversificare l’approccio nell’insegnamento e favorire l’intesa tra chi insegna e chi apprende i contenuti didattici con il fine ultimo di costruire un dialogo educativo che favorisca l’apprendimento.
Inoltre, un altro fattore che sicuramente non agevola l’apprendimento è il fatto che molti alunni percepiscono troppo rigide e limitanti le regole sull’utilizzo delle nuove tecnologie (per esempio il semplice fatto che non sempre si possa tenere il tablet sul banco). Sarebbe preferibile dare più fiducia agli alunni e responsabilizzarli per fare in modo che anche in un ambiente scolastico si sentano a loro agio. Sottolineo anche un altro aspetto: talvolta alcuni docenti utilizzano metodi di insegnamento che a qualche studente potrebbero risultare troppo severi. Ciò provoca sempre più spesso in caratteri introversi e riservati un disagio che peggiora la vita scolastica dello studente. Come ultima osservazione sottolineo che, nonostante tutte le attenzioni verso gli studenti con bisogni educativi speciali, le scuole in generale non riescono sempre a fare in modo che le misure adottate rispecchino i bisogni dello studente.
Detto ciò, è chiaro che la società fotografata dall’ultimo rapporto CENSIS ha grandi margini di miglioramento e in questo percorso la scuola deve fare la sua parte. Tuttavia, a mio avviso, potrebbe contribuire più efficacemente con la collaborazione di tutti, studenti e insegnanti in primis.
Francesco Busato Grazioli